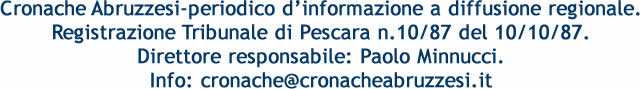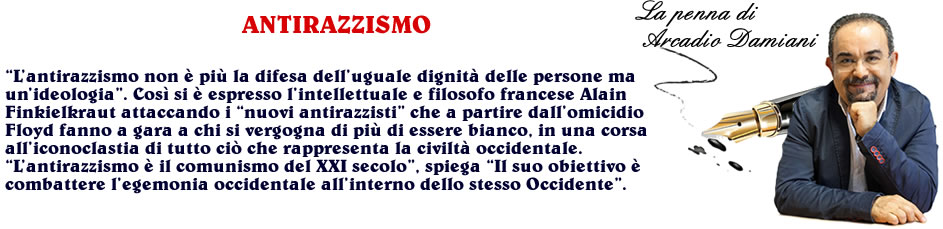
Termine che tradotto letteralmente dalla lingua anglosassone significa “lavoro intelligente” viene usato a sproposito nel nostro Paese in quanto nei luoghi originali del termine viene usato meglio “working from home” cioè “lavoro da casa” o “telelavoro”. Ma da noi per invogliare questa forma operativa si fa credere che chi lo esegue sia in realtà “smart”, intelligente. E ciò non corrisponde alla realtà perché chi può lavorare da casa può essere un semplice impiegato dell’anagrafe con un QI medio-basso mentre chi non può eseguirlo, come ad esempio un ingegnere minerario che ha certamente un QI più elevato, ha bisogno di coordinare i lavori sul posto, ad esempio su una piattaforma estrattiva in mare aperto. Il giornalista Riccardo Luna su “la Repubblica” tesse le lodi dello smart working in quanto in questi mesi estivi ha viaggiato molto nel nostro Paese riscoprendo borghi minuscoli di cui non si parla mai, le bellezze della nostra Italia, ma nel contempo non ha mai smesso di lavorare. E come lui molti altri giornalisti che continuavano a lavorare dalla casa dove trascorrevano le vacanze con la famiglia. E rileva che oltre ai giornalisti ci sono milioni di italiani in “smart working” da marzo che hanno lavorato “everywhere, anytime”, in ogni luogo ed in ogni tempo, secondo la definizione di un report dell’Organizzazione mondiale del lavoro. Certo una volta c’era il telegrafo, poi il telefono, poi il fax ma oggi c’è Internet e se non c’è ancora la “fibra” c’è il 4G che ti permette con il telefonino di scaricare la posta, leggere quotidiani, vedere i Tg o una partita di calcio in “streaming” impensabile solo 5 anni fa. E come copertura di rete non siamo messi male, per la connettività lasciamo un po’ a desiderare e dobbiamo migliorare con la digitalizzazione dei servizi ed investire sul 5G, portando fibra e rete dove mancano. Lo smart working non è una moda e non è un fenomeno italiano: è un nuovo modo di concepire il rapporto fra datore di lavoro e dipendenti, una rivoluzione che sta avvenendo in tutto il mondo sviluppato: i big della Silicon Valley come Google, Twitter, Facebook, Amazon, Microsoft hanno adottato questa modalità di lavoro per decine di migliaia di persone. Perché allora anche noi non potremmo diventare un paradiso di “smart-worker”? Sono certo che anche nel nostro Paese, anche se con maggiore lentezza, si arriverà ad avere una discreta quota di smart worker causa un processo inarrestabile di trasformazione digitale della nostra vita che va dall’innocua(?) lettura di un “QRcode”, o pagamenti “on-line” ma che potrà varcare anche alcuni limiti del ponderabile come il “chip” sottopelle come cartellino di presenza fino al “chip” intracerebrale del progetto “Neuralink” (interfaccia cervello-computer) finanziato da Elon Musk che apre la porta al “transumanesimo” dei “Cyborg” di Ray Kurzweil, grande teorico della “singolarità” ovvero il momento in cui “l’intelligenza artificiale diverrà effettivamente autonoma e capire esattamente come funziona il cervello umano e poi usare i metodi scoperti per capire meglio noi stessi, per riparare il cervello quando necessario e per creare macchine ancora più intelligenti perché l’intelligenza è il fenomeno più importante dell’universo, è in grado di trascendere i suoi limiti naturali e di trasformare il mondo a propria immagine…bisogna ingegnerizzare il cervello umano per estendere grandemente la potenza della nostra intelligenza”. L’idea di questi nuovi maghi alchimisti si avvale dell’apporto degli odierni esperti di informatica: coniugare le tecniche di laboratorio con le dottrine gnostiche nell’intento malcelato di dominare il mondo. Ma quando si cerca di accrescere l’umano con l’ingegneria, di umano resta ben poco. Questo solo per essere consapevoli di un possibile futuro distopico e per tornare sull’argomento lo smart working rimane una grande opportunità in un mondo sempre più interconnesso ove il flusso di informazioni supera qualche miliardo di dati al secondo. Ma il “lavoro da remoto” è sempre esistito, una volta più difficile e limitato come i servizi dei giornalisti inviati nel mondo che fornivano informazioni ed immagini dai più disparati luoghi del pianeta, oggi molto più facilitato e alla portata di tutti con i collegamenti o le videoconferenze via Skype. Ci sarebbero però alcune questioni meritevoli di essere valutate perché come sempre non è tutt’oro ciò che luce. La prima è che sia un metodo utile in fase emergenziale ossia per qualsiasi motivo sia necessario evitare contatti o limitare gli spostamenti il telelavoro è certamente una risorsa. Di qui a considerare come desiderabile routine il nuovo rapporto fra datore di lavoro e dipendenti ce ne corre. Questa forzatura cui assistiamo in questi giorni deve indurci a qualche riflessione specie se si usa il pericolo della pandemia ricorrente come mezzo per ridurre la vita di ufficio, scuola, università, ed altre attività collettive. Abbiamo allora professori che non vogliono rientrare a scuola per pura del contagio (insegnanti fragili), università che preferiscono lezioni on line con cattedre vuote, uffici pubblici deserti con impiegati che dovrebbero lavorare da casa ma che spesso, specie se pubblici, sono difficili da reperire con una riduzione della produttività già calcolata in misura del 30%. Stranamente chi ci ha rimesso di più le penne per il Covid sono stati medici ed infermieri sempre in trincea nei PS e reparti di terapia intensiva con indici di rischio ben più elevati rispetto ai professori e per i quali non è possibile lo “smart working”: basta vedere i super affollamenti nei PS ma con le dovute precauzioni come mascherine o visiere plastiche sembra che non ci siano più stati decessi nel personale sanitario. E sono sempre più gli insegnanti che negano che si possa imparare tutto dai video, peraltro immersi nell’inferno casalingo di più computer connessi con bambini ed adolescenti da accudire e genitori disperati, ed imprenditori per niente convinti che fabbrica e azienda siano realtà superate. E sospettiamo che dietro il diluvio di domande d’esenzione indirizzate ai dirigenti scolastici non si celino solo pericolose patologie ma anche schiere di debosciati attratti dall’idea di trascorrere altri mesi sul divano di casa anziché in cattedra. Federico Rampini uno dei pochi giornalisti intelligenti di sinistra è stato “linciato” dai suoi sodali per aver detto con semplicità e periodare ben tornito che “i compagni lavoratori statali sono dei lazzaroni che con un falso smart working si sono goduti furbescamente ferie rubate ai cittadini che gli pagano lo stipendio”. Come ha ribadito il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci affermando che l’80% dei suoi 13.000 dipendenti non fa nulla e da casa meno di nulla. E con i sindacati che hanno difeso le ferie come diritto istituzionale irrinunciabile anche dopo 4 mesi di lockdown. E Rampini ha peggiorato la sua situazione in quanto dal pulpito sinistro ha negato che in Italia ci sia un qualsivoglia pericolo fascista ed ha rovinato la retorica degli “ultimi”, spiegando che i dimenticati dalla sinistra e dalla Chiesa non sono gli stranieri ma i “penultimi”, quelli per cui non corre lo stipendio sicuro e cui tocca vivere in periferie pestilenziali. I penultimi sono esattamente i “non-statali”. E se nessuno lavora chi ci salverà dalla crisi? Ma certo i dieci milioni di occupati pubblici che dal loro habitus parassitario si risentono quando si ricordano queste verità elementari ma non è una buona ragione per dimenticarsene semmai è una buona ragione per continuare a rinfacciarle. L’Osservatorio del Politecnico afferma che in Italia lo smart working è fattibile per un lavoratore su tre in risposta alla banca d’investimenti londinese Schroders che secondo un sondaggio interno riferisce che i sui impiegati preferiscono in massa il lavoro da casa ed allora “smart working per sempre” con la relazione tra comunità ed imprese che non sarà più la stessa con l’ufficio che diventerà un posto d’incontro dove riunire la squadra per parlare ma la gente lavorerà da casa. Questa scelta ha fatto trasalire il sindaco di Londra Sadiq Khan “se tutti decidiamo di lavorare da casa il centro di Londra avrà grandissimi problemi. Tante piccole imprese si sostengono con il viavai dei lavoratori come i bar, ristoranti, tintorie, calzolai e così via”. Per informatici e bancari non credo ci sia molta differenza del vivere il loro lavoro “ingabbiati” dinnanzi ad un Pc: da casa o in ufficio non è molta differenza. Per molti altri si! C’è una parte di relazione, quella dei corridoi, del caffè alla macchinetta che non è solo socialità ma anche motore per l’innovazione come riportano alcuni esperti come Maria Pisante convinta che molti lavoratori sceglierebbero un telelavoro solo “parziale”. “C’è necessità di avere un qualche rapporto umano, quello destrutturato. In una call, nei video bisogna sempre essere efficienti, puntare all’obiettivo, con agenda alla mano, slot di tempo dedicati. Non c’è il pensiero liberale che fa nascere le idee. Perché è dal relazionarsi fisicamente che devono succedere delle cose, diverse da quelle che posso fare da solo in casa. E quindi incontrare persone, confrontarsi, perché è di questo che si nutre l’innovazione”. La tifoseria del lavoro da casa come afferma la giornalista Azzurra Barbuto è composta da chi non è stato danneggiato dalla chiusura di uffici, scuole ed attività di ogni tipo, da chi considera il lavoro una noia, da chi rifugge il confronto, da chi non ha più nulla da apprendere e da condividere, da chi se ne fotte dei battiti cardiaci, anche aritmici, di una città che vive soprattutto offrendo i propri servizi. Ogni metro che regaliamo al “virtuale” è una luce delle nostre città che si spegne, è la sottrazione di un respiro che ci ha reso diversi ed eccellenti. Oggi sappiamo che la permanenza nella propria abitazione di milioni di impiegati sia pubblici che privati favorisce la disoccupazione, conduce al fallimento di numerose imprese che basavano i loro introiti sulla presenza di lavoratori, praticamente ridotta al lumicino e determina anche ansia, paura, insoddisfazione, persino infelicità nel lavoratore che, isolato, perde la contezza del suo rapporto col superiore, sentendosi minacciato da ulteriori presenze che potrebbero assolvere il suo compito anche meglio e con maggiore spregiudicatezza e di cui ignora l’esistenza e subendo una drastica riduzione di quella socialità nonché la perdita del confronto continuo e diretto con i colleghi che costituiva un’occasione di scambio di idee crescita ed arricchimento ed un maggiore controllo sulla propria esistenza professionale. Stranamente ma prevedibilmente chi rifiuta la prospettiva dello smart working sono soprattutto i giovani pur maggiormente avvezzi all’uso di tecnologie. E’ quanto emerge da alcuni sondaggi nei paesi anglosassoni riguardo la “job satisfaction” dei telelavoratori. Quindi i ragazzi preferirebbero svegliarsi presto, prendere i mezzi pubblici ed imbottigliarsi nel traffico pur di avere un motivo valido per trascorrere una giornata fuori dal perimetro domestico, venuto a noia. In fondo ciò che ci rende maggiormente efficienti è il benessere mentale assicurato da uno stato di appagamento e serenità che non sempre coincide con l’essere sigillato nel proprio antro facendo la spola tra frigorifero e postazione Pc, perché l’uomo è un animale sociale che si lagna spesso del prossimo vicino ma che non può farne a meno pena il deperimento interiore. L’ufficio lungi dall’essere un luogo ricreativo tuttavia rappresenta un posto dove si fanno conoscenze, si creano amicizie, si intrattengono conversazioni reali, si costruiscono reti sociali e ci si può anche innamorare. Non si può vivere da semplici servi della gleba rispondenti solo ad ordini via etere e se uno “sguardo” vale molto più di mille parole come possiamo rinunciare a questo utilissimo ed imprescindibile mezzo di comunicazione? Amore virtuale, lavoro virtuale, eucarestie virtuali, scuole virtuali, processi virtuali ma è un duro colpo per chi vorrebbe reinventare l’uomo con Internet ed una ricerca USA conferma l’inutilità di trovare l’anima gemella in Rete perché la nuvola del web ignora il sistema degli affetti e del sentimento e si rischia di interagire con un altro/a di cui può essere difficile liberarsi. Inoltre la nuova religione dei “like” è ricca di morti e nefandezze di sempre più persone che nella virtualità esistenziale si avvicinano a situazioni reali molto pericolose che possono validare lo scopo della loro esistenza: autostima misurata solo dal numero dei click ottenuti. Ma a quale prezzo? Le piattaforme social sono come una droga: centinaia di persone sono morte cercando di fotografarsi in posizioni pericolose nel tentativo disperato di ottenere l’approvazione degli altri. In India ci si sdraia sulle rotaie per una foto mentre passa il treno ed in Russia in tanti precipitano dai grattacieli per un selfie. Ai miei tempi per un cristiano, l’autostima nasceva solo dal rapporto con Dio. Il sociologo Maffesoli professore alla Sorbona, che ha appena pubblicato in Francia il suo nuovo libro “La Nostalgie du sacre”, smonta il mito del progresso digitale che non può sostituire l’esperienza fisica: tutta la potenza del sacro contro il culto della tecnica. Chi vincerà la battaglia?